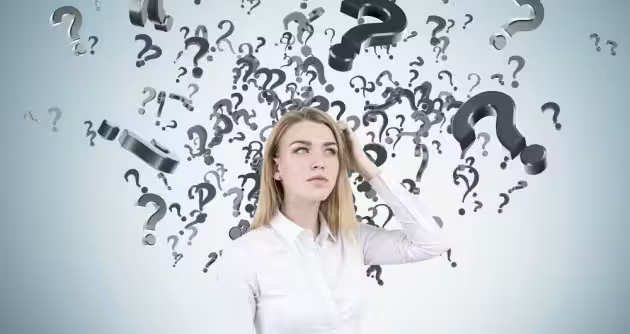
Dopo anni di dibattito sul rinnovamento delle sanzioni fiscali, il legislatore ha definito con il Decreto Legislativo 173/2024 (Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali) un nuovo assetto normativo, operativo dal 1° gennaio 2026. Un punto di partenza fondamentale per padroneggiare la materia resta la distinzione tra sanzioni amministrative e penali: queste ultime colpiscono condotte di particolare gravità, quali la falsificazione documentale o la sottrazione fraudolenta al fisco.
Le sanzioni amministrative – già oggetto della riforma “D. Lgs. 87/2024”, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 – coinvolgono il pagamento di somme proporzionali all’imposta evasa o non dichiarata, secondo aliquote in fase di transizione e nuove riduzioni per ravvedimento (1/9, 1/8, 1/7).
Dal 2026, il D.Lgs. 173/2024 coordina la nuova disciplina, sostituendo integralmente il regime previgente. Il titolo dell’articolo è stato aggiornato per riflettere correttamente l’ambito trattato, che include riferimenti sia alle sanzioni penali che amministrative. In alternativa, si potrebbe valutare la redazione di due articoli distinti, uno per ciascun regime, al fine di garantire maggiore chiarezza espositiva e specializzazione tematica.
Iter normativo e riferimenti utili
D.Lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”): resta tutt’oggi il pilastro della materia penale tributaria, integrato dalle modifiche del D.Lgs. 158/2015 e dalla riforma 2024–2025.
D.Lgs. 173/2024 (Testo Unico): coordina la nuova disciplina in materia amministrativa e penale. Le fonti ufficiali e materiali di consultazione, inclusa la tabella unica delle soglie di punibilità e note operative della Guardia di Finanza, sono rintracciabili nella sezione Sanzioni Penali e Riforme di def.finanze.it.
Sanzioni penali tributarie: riferimenti normativi e periodi applicativi
| Periodo di commissione | Normativa applicabile | Note principali |
|---|---|---|
| Fino al 31/12/2025 | D.Lgs. 74/2000 (testo coordinato), D.Lgs. 158/2015 | Soglie e sanzioni previgenti, interpretazioni consolidate |
| Dal 01/01/2026 | D.Lgs. 173/2024 (artt. 85–102) | Coordinamento penale/amministrativo, razionalizzazione casi di non punibilità |
Principali reati penali tributari e soglie di punibilità (in vigore 2025–2026)
| Reato | Articolo | Soglia penale | Sanzione prevista |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione fraudolenta | art. 2 D.Lgs. 74/2000 | Imposta evasa > € 150.000 | Reclusione 3 – 8 anni |
| Dichiarazione infedele | art. 4 D.Lgs. 74/2000 | > € 150.000 imposta evasa | Reclusione 2 – 4 anni |
| Omessa dichiarazione | art. 5 D.Lgs. 74/2000 | > € 50.000 imposta evasa | 1 anno e 6 mesi – 4 anni |
| Omesso versamento IVA | art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 | > € 250.000 | 6 mesi – 2 anni |
| Omesso versamento ritenute | art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 | > € 150.000 | 6 mesi – 2 anni |
| Indebita compensazione (crediti non spettanti) | art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 | > € 50.000 | 6 mesi – 2 anni |
| Indebita compensazione (crediti inesistenti) | art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 | Nessuna soglia | 1 anno e 6 mesi – 6 anni |
Cause di non punibilità e ravvedimento operoso
Dal 2026, con l’entrata in vigore del Testo Unico (D.Lgs. 173/2024), le soglie penali per i reati fiscali più gravi vengono confermate, ma il rapporto tra la condotta illecita e l’adempimento tributario assume un rilievo decisivo ai fini della punibilità. In particolare, il ravvedimento operoso diventa uno strumento centrale: affinché sia idoneo a escludere la responsabilità penale, deve essere effettuato prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, deve comprendere il versamento integrale dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte, e deve risultare documentalmente tracciabile. Il pagamento integrale e tempestivo del debito tributario, anche al di fuori del ravvedimento, può costituire causa di non punibilità se avviene entro termini definiti dal nuovo impianto normativo, e se accompagnato da una condotta collaborativa e trasparente. La collaborazione attiva con l’amministrazione – ad esempio mediante l’adesione spontanea al contraddittorio, la rinuncia a impugnazioni pretestuose o la produzione di documentazione utile – può concorrere all’esclusione della punibilità o alla significativa attenuazione della pena.
Questi elementi non hanno solo valore attenuativo: in presenza di condotte tempestive e regolarizzanti, il procedimento penale può essere archiviato per insussistenza del reato, oppure può concludersi con una sentenza di non luogo a procedere. È quindi fondamentale, per il contribuente e per il consulente, valutare tempestivamente l’opportunità di attivare strumenti di regolarizzazione prima che si concretizzi l’intervento repressivo. Il nuovo impianto normativo non si limita a punire, ma premia la compliance volontaria e la responsabilità fiscale, trasformando il ravvedimento da strumento amministrativo a presidio penale.
Coordinamento tra sanzioni penali e amministrative
Il coordinamento tra sanzioni penali e amministrative rappresenta uno degli aspetti più innovativi introdotti dal D.Lgs. 173/2024. La nuova disciplina supera la tradizionale separazione tra i due regimi, prevedendo criteri di interazione che impongono una valutazione congiunta delle condotte, delle soglie di punibilità e delle eventuali cause esimenti. Questo approccio consente di evitare duplicazioni sanzionatorie e di garantire una risposta proporzionata e coerente alle violazioni tributarie.
Ad esempio, si consideri il caso di una dichiarazione infedele con imposta evasa pari a €120.000, quindi sotto la soglia penale di €150.000 prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. In regime previgente, tale condotta avrebbe generato esclusivamente una sanzione amministrativa. Tuttavia, se la stessa dichiarazione è accompagnata da una compensazione indebita di crediti inesistenti per €60.000, si configura anche la fattispecie penale prevista dall’art. 10-quater, comma 2, che non prevede soglia minima. In assenza di ravvedimento operoso o pagamento tempestivo, il contribuente può essere perseguito penalmente per la compensazione, con effetti che si estendono anche alla valutazione complessiva della condotta dichiarativa.
In questo scenario, il coordinamento tra i due regimi consente all’autorità procedente di considerare l’intera condotta come unitaria, valutando se l’infedeltà dichiarativa sia funzionale alla compensazione indebita e se vi siano elementi di dolo, anche implicito. Se invece il contribuente ha effettuato un ravvedimento operoso completo prima dell’accertamento – comprensivo del versamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte – la responsabilità penale può essere esclusa, e la violazione trattata esclusivamente in sede amministrativa.
La corretta qualificazione giuridica richiede quindi non solo l’analisi delle soglie, ma anche la verifica dell’intenzionalità, della tempestività del ravvedimento e della natura dei crediti compensati. Il nuovo impianto normativo impone una lettura sistemica delle violazioni, in cui la distinzione tra illecito penale e amministrativo non è più rigida, ma dinamica e interdipendente.
Pene accessorie: quadro aggiornato
Le pene accessorie previste dal D. Lgs. 173/2024 rappresentano un rafforzamento del sistema sanzionatorio penale tributario, con l’obiettivo di colpire non solo la condotta illecita ma anche la capacità del soggetto condannato di reiterare o trarre vantaggio dalla violazione. Queste misure si applicano in caso di condanna definitiva per reati tributari, e la loro adozione dipende dalla gravità del fatto, dalla presenza di dolo accertato e dalla tipologia di reato contestato.
Alcune pene accessorie, come la confisca per equivalente, sono di applicazione obbligatoria e automatica, salvo che il contribuente dimostri l’assenza di vantaggio economico diretto. Altre, come l’interdizione dai pubblici uffici o il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, sono invece discrezionali e rientrano nella valutazione del giudice, che può applicarle in funzione della pericolosità sociale del soggetto e della reiterazione delle condotte.
Il Testo Unico armonizza queste misure con il regime amministrativo, prevedendo criteri di proporzionalità e coordinamento. Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali pene accessorie e delle condizioni per la loro applicazione:
| Pena accessoria | Presupposti di applicazione | Normativa |
|---|---|---|
| Interdizione dai pubblici uffici | Reati con dolo accertato | Art. 98 D.Lgs. 173/2024 |
| Confisca per equivalente | Importi evasi o compensati indebitamente | Art. 99 D.Lgs. 173/2024 |
| Divieto di contrattare con la PA | Condanne definitive | Art. 100 D.Lgs. 173/2024 |
Tabella comparativa: D.Lgs. 74/2000 vs D.Lgs. 173/2024
| Reato | D.Lgs. 74/2000 (fino al 31/12/2025) | D.Lgs. 173/2024 (dal 01/01/2026) | Novità e note operative |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione fraudolenta (art. 2) |
Soglia: imposta evasa > €150.000 Pena: reclusione 3–8 anni |
Soglia confermata Pena confermata |
Coordinamento con cause esimenti (ravvedimento, pagamento) |
| Dichiarazione infedele (art. 4) |
Soglia: > €150.000 imposta evasa Pena: reclusione 2–4 anni |
Soglia confermata Pena confermata |
Possibile esclusione pena se pagamento tempestivo |
| Omessa dichiarazione (art. 5) |
Soglia: > €50.000 imposta evasa Pena: 1 anno e 6 mesi – 4 anni |
Soglia confermata Pena confermata |
Ravvedimento tempestivo può escludere punibilità |
| Omesso versamento IVA (art. 10-ter) |
Soglia: > €250.000 Pena: 6 mesi – 2 anni |
Soglia confermata Pena confermata |
Pagamento entro termini può evitare il reato |
| Omesso versamento ritenute (art. 10-bis) |
Soglia: > €150.000 Pena: 6 mesi – 2 anni |
Soglia confermata Pena confermata |
Collaborazione attiva rilevante ai fini esimenti |
| Indebita compensazione – crediti non spettanti (art. 10-quater) |
Soglia: > €50.000 Pena: 6 mesi – 2 anni |
Soglia confermata Pena confermata |
Coordinamento con regime amministrativo |
| Indebita compensazione – crediti inesistenti (art. 10-quater) |
Nessuna soglia Pena: 1 anno e 6 mesi – 6 anni |
Nessuna soglia Pena confermata |
Reato sempre punibile, anche sotto soglia |
Aspetti collegati rilevanti: commento sintetico
Procedura di accertamento e fasi del ravvedimento
La tempistica con cui interviene il ravvedimento operoso è centrale per accedere alle cause di non punibilità penale: la regolarizzazione dev’essere completata prima dell’avvio di controlli formali o dell’accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate. Se, ad esempio, un contribuente effettua il ravvedimento dopo una comunicazione d’irregolarità ma prima della notifica del processo verbale di constatazione o dell’avviso di accertamento, può venire esclusa la punibilità penale. Una possibile “timeline” è: 1) omissione/errore → 2) ravvedimento tempestivo → 3) eventuale controllo → 4) esito senza rilievi penali.
Recidiva e reiterazione delle condotte
La riforma rafforza l’attenzione sugli effetti della recidiva e della pluralità di violazioni: la reiterazione di comportamenti illeciti può incidere sulle pene accessorie, con applicazione più frequente di misure interdittive (es. dall’attività imprenditoriale) o di confisca estesa, anche in assenza di vantaggio patrimoniale significativo. La valutazione della recidiva è quindi rilevante nella scelta delle misure aggiuntive.
Compliance e strumenti deflattivi del contenzioso
L’articolazione tra strumenti deflattivi (adesione, definizione agevolata, mediazione) e sanzioni penali è sempre più stretta: la collaborazione con il Fisco in fase precontenziosa può costituire attenuante o, in alcuni casi, portare all’estinzione del reato se accompagnata da integrale regolarizzazione. In materia di adesione o accordi, la giurisprudenza valuta positivamente la volontà di definire le controversie, soprattutto quando interviene prima dell’apertura dei procedimenti penali.
Giurisprudenza e prassi recenti
Le prime interpretazioni (es. circolari MEF e Agenzia delle Entrate 2025) sottolineano il favor per le condotte collaborative e per il ravvedimento tempestivo, anche quando il contribuente agisce sulla base di comunicazioni di compliance, purché prima di una vera e propria attività ispettiva. Inoltre, si sta consolidando la prassi secondo cui il pagamento integrale anticipato costituisce causa di esclusione della punibilità, ma restano dubbi applicativi su casi di mera comunicazione di irregolarità o di autoaccertamento. Sarà necessario monitorare la casistica dei primi mesi di applicazione della riforma per individuare indirizzi univoci.
Criticità aperte e temi ancora dibattuti
Nonostante la riforma abbia notevolmente razionalizzato il sistema delle sanzioni tributarie, permangono alcune criticità interpretative e applicative che meritano attenzione. In particolare, restano oggetto di discussione:
-
la prova del dolo nei reati tributari, che richiede di accertare non solo l’elemento soggettivo intenzionale, ma anche la consapevolezza dell’illiceità e la volontà di evadere;
-
le modalità di quantificazione e accertamento concreto del vantaggio economico ottenuto, tema cruciale sia ai fini della determinazione della pena che delle misure accessorie;
-
il delicato profilo dell’eventuale retroattività favorevole delle nuove soglie di punibilità e delle pene ridotte, secondo i principi dettati dall’art. 2 c.p., che potrebbero incidere sui procedimenti pendenti, con conseguenze pratiche da valutare caso per caso.
Questi aspetti restano al centro dell’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, e sarà importante monitorare i primi orientamenti applicativi delle autorità competenti, nonché possibili interventi chiarificatori da parte del legislatore o dell’Amministrazione finanziaria.
Fonti utili di approfondimento, guidate dal sito def.finanze.it:
-
Sezione Sanzioni penali tributarie (Testi normativi, circolari, tabelle ufficiali)
-
Testo completo D.Lgs. 74/2000 e Testo Unico Sanzioni D.Lgs. 173/2024 (Normattiva, def.finanze.it)
-
FAQ ministeriali, Note e Vademecum aggiornati alle riforme fiscali 2024/2025
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2024-11-05%3B173
- https://onida.sssr.it/sanzioni-tributarie-2026/
- https://www.torinoconsulting.it/wp-content/uploads/2018/10/Guida_Le_sanzioni_tributarie_e_penali.pdf
- https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14322-sanzioni-tributarie-penali-e-amministrative.html
- https://www.avvocatobertaggia.org/reati-penali-tributari/
- https://web.unica.it/static/resources/cms/documents/Lezionen.10Sanzionipenalitributarie2.pptx
- https://avvocatomattiafontana.com/reati-tributari/
- https://www.programmagoverno.gov.it/it/approfondimenti/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-di-rilievo-del-governo/riforma-fiscale/testo-unico-delle-sanzioni-tributarie-amministrative-e-penali/
- https://www.soluzionialdebito.it/2025/02/23/nuove-sanzioni-tributarie/
- https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/riforma-fiscale/sanzioni-tributarie/sanzioni-penali
- https://pg-perugia.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/DL%202024%20173%20Testo%20Unico%20sanzioni%20tributarie.pdf
- https://verona.commercialisti.it/wp-content/uploads/2025/05/Slide-Matteo-Migazzi.pdf
- https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15970-i-reati-fiscali-nel-decreto-sanzioni-tributarie.html
- https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-convegni-2024/le-nuove-sanzioni-tributarie-spunti-di-riflessione-e-casi-pratici-(02-12-24).pdf?sfvrsn=3fe8b6b1_2
- https://studiobandera.it/wp-content/uploads/2024/09/CIRCOLARE-22_2024_Riforma-delle-sanzioni-tributarie.pdf
- https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?idDocMaster=10953502&idDataBanks=250
- https://www.soluzionetasse.com/sanzioni-tributarie-quali-sono/
- https://www.interstudio.it/approfondimenti/sanzioni-penali-tributarie-riforma-dlgs-n-1582015/
- https://www.tramontelli.it/riforma-delle-sanzioni-fiscali-penali-e-amministrative-1-parte/
- https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-unico-delle-sanzioni-tributarie-amministrative-e-penali/
- https://shop.seac.it/guide-operative-e-professionali/11277-sanzioni-tributarie-9791254653470.html



